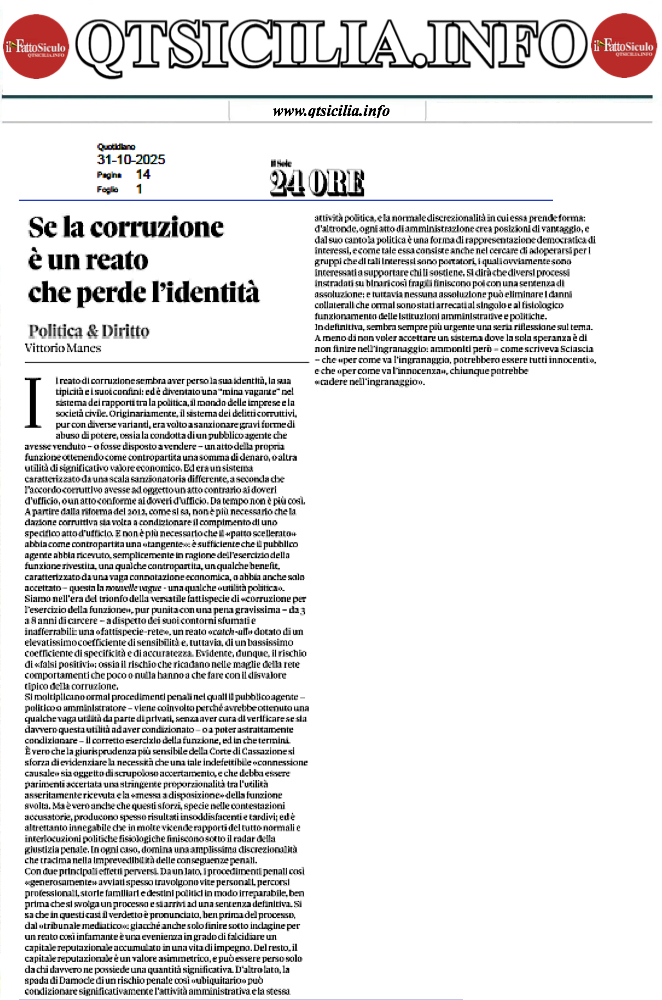
Da quando è stato abolito il reato di abuso d’ufficio è diventato tutto corruzione, certamente un’anomalia, come spiega il prof. Vittorio Manes che afferma, tra l’altro, nella sua dissertazione: “i procedimenti penali così «generosamente» avviati spesso travolgono vite personali, percorsi professionali, storie familiari e destini politici in modo irreparabile, ben prima che si svolga un processo e si arrivi ad una sentenza definitiva”.
Leggiamo attentamente l’analisi puntuale che si applica a quello che accade oggi e che notiamo tutti:
«Il reato di corruzione sembra aver perso la sua identità, la sua
tipicità e i suoi confini: ed è diventato una “mina vagante” nel
sistema dei rapporti tra la politica, il mondo delle imprese e la
società civile. Originariamente, il sistema dei delitti corruttivi,
pur con diverse varianti, era volto a sanzionare gravi forme di
abuso di potere, ossia la condotta di un pubblico agente che
avesse venduto – o fosse disposto a vendere – un atto della propria
funzione ottenendo come contropartita una somma di denaro, o altra
utilità di significativo valore economico. Ed era un sistema
caratterizzato da una scala sanzionatoria differente, a seconda che
l’accordo corruttivo avesse ad oggetto un atto contrario ai doveri
d’ufficio, o un atto conforme ai doveri d’ufficio. Da tempo non è più così.
A partire dalla riforma del 2012, come si sa, non è più necessario che la
dazione corruttiva sia volta a condizionare il compimento di uno
specifico atto d’ufficio. E non è più necessario che il «patto scellerato»
abbia come contropartita una «tangente»: è sufficiente che il pubblico
agente abbia ricevuto, semplicemente in ragione dell’esercizio della
funzione rivestita, una qualche contropartita, un qualche benefit,
caratterizzato da una vaga connotazione economica, o abbia anche solo
accettato – questa la nouvelle vague – una qualche «utilità politica».
Siamo nell’era del trionfo della versatile fattispecie di «corruzione per
l’esercizio della funzione», pur punita con una pena gravissima – da 3
a 8 annidi carcere – a dispetto dei suoi contorni sfumati e
inafferrabili: una «fattispecie-rete», un reato «catch-ail» dotato di un
elevatissimo coefficiente di sensibilità e, tuttavia, di un bassissimo
coefficiente di specificità e di accuratezza. Evidente, dunque, il rischio
di «falsi positivi»: ossia il rischio che ricadano nelle maglie della rete
comportamenti che poco o nulla hanno a che fare con il disvalore
tipico della corruzione.
Si moltiplicano ormai procedimenti penali nei quali il pubblico agente –
politico o amministratore – viene coinvolto perché avrebbe ottenuto una
qualche vaga utilità da parte di privati, senza aver cura di verificare se sia
davvero questa utilità ad aver condizionato – o a poter astrattamente
condizionare – il corretto esercizio della funzione, ed in che termini.
È vero che la giurisprudenza più sensibile della Corte di Cassazione si
sforza di evidenziare la necessità che una tale indefettibile «connessione
causale» sia oggetto di scrupoloso accertamento, e che debba essere
parimenti accertata una stringente proporzionalità tra l’utilità
asseritamente ricevuta e la «messa a disposizione» della funzione
svolta. Ma è vero anche che questi sforzi, specie nelle contestazioni
accusatorie, producono spesso risultati insoddisfacenti e tardivi; ed è
altrettanto innegabile che in molte vicende rapporti del tutto normali e
interlocuzioni politiche fisiologiche finiscono sotto il radar della
giustizia penale. In ogni caso, domina una amplissima discrezionalità
che tracima nella imprevedibilità delle conseguenze penali.
Con due principali effetti perversi. Da un lato, i procedimenti penali così
«generosamente» avviati spesso travolgono vite personali, percorsi
professionali, storie familiari e destini politici in modo irreparabile, ben
prima che si svolga un processo e si arrivi ad una sentenza definitiva. Si
sa che in questi casi il verdetto è pronunciato, ben prima del processo,
dal «tribunale mediatico»: giacché anche solo finire sotto indagine per
un reato così infamante è una evenienza in grado di falcidiare un
capitale reputazionale accumulato in una vita di impegno. Del resto, il
capitale reputazionale è un valore asimmetrico, e può essere perso solo
da chi davvero ne possiede una quantità significativa. D’altro lato, la
spada di Damocle di un rischio penale così «ubiquitario» può
condizionare significativamente l’attività amministrativa e la stessa
attività politica, e la normale discrezionalità in cui essa prende forma:
d’altronde, ogni atto di amministrazione crea posizioni di vantaggio, e
dal suo canto la politica è una forma di rappresentazione democratica di
interessi, e come tale essa consiste anche nel cercare di adoperarsi per i
gruppi che di tali interessi sono portatori, i quali ovviamente sono
interessati a supportare chili sostiene. Si dirà che diversi processi
instradati su binari così fragili finiscono poi con una sentenza di
assoluzione: e tuttavia nessuna assoluzione può eliminare i danni
collaterali che ormai sono stati arrecati al singolo e al fisiologico
funzionamento delle istituzioni amministrative e politiche.
In definitiva, sembra sempre più urgente una seria riflessione sul tema.
A meno di non voler accettare un sistema dove la sola speranza è di
non finire nell’ingranaggio: ammoniti però – come scriveva Sciascia
– che «per come va l’ingranaggio, potrebbero essere tutti innocenti»,
e che «per come va l’innocenza», chiunque potrebbe
«cadere nell’ingranaggio».
VITTORIO MANES
Professore ordinario Dipartimento di Scienze Giuridiche Diritto penale